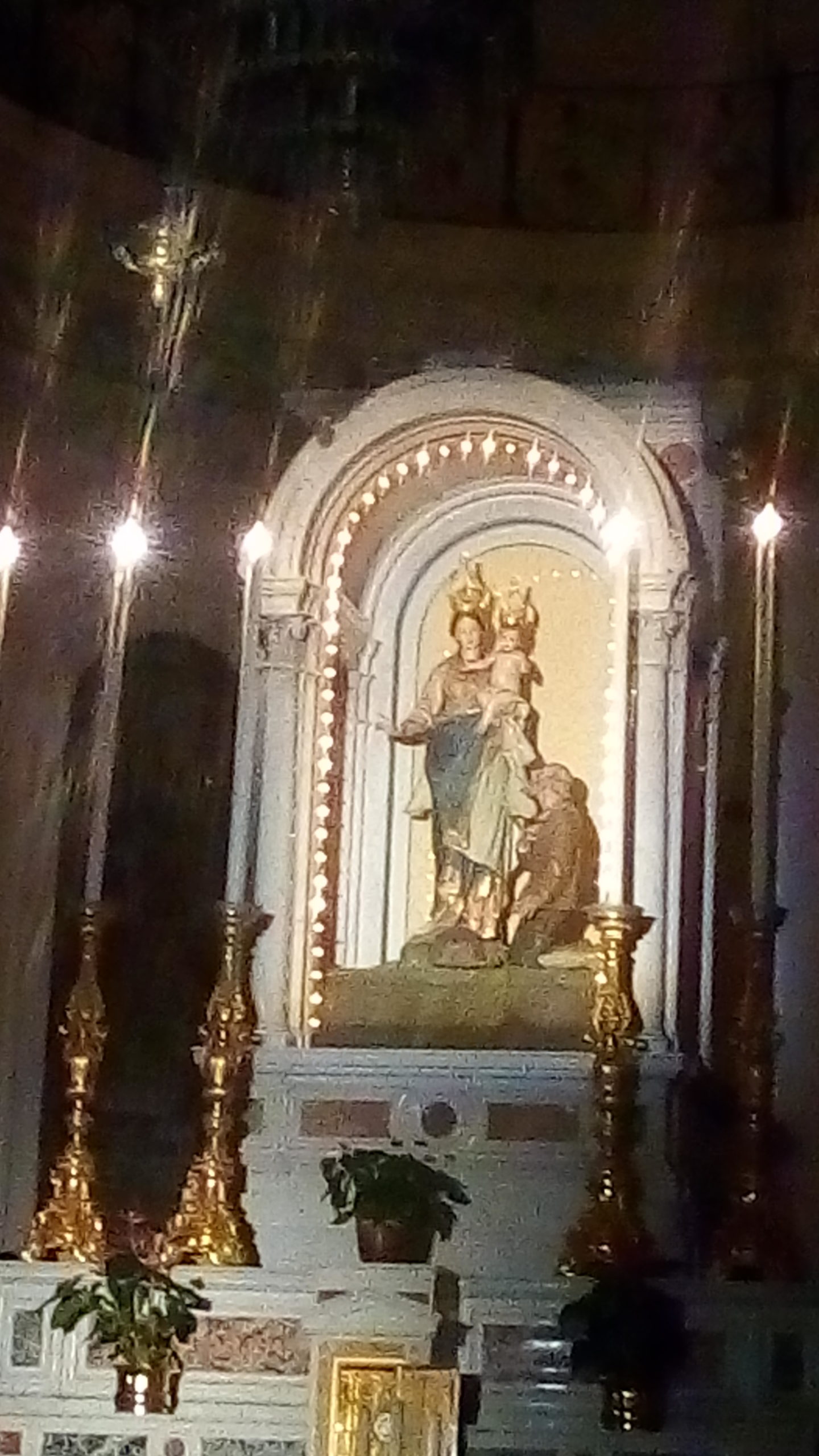“Io non sono nessuno”, la frase irrompe nel giardino di Mario mentre la pronipote gioca sotto gli alberi. “Davvero non ci potevo credere che quella ragazza non mi riconoscesse quando noi, umili contadini, avevamo accolto in paese lei e tutti gli sfollati di Sestri; e così , quando mi ha chiesto chi fossi e perché pensavo di poter lavorare lì, le ho detto: chi sono? Io non sono nessuno”. Le sue parole sono secche perché parlare di ingratitudine brucia la gola, asciuga il palato: “Volevo solo poter fare il cameriere e lei fingeva di non conoscermi…Ma vede, la guerra era finita e i ricchi tornavano ad essere ricchi, i contadini riprendevano a fare i contadini perché la vita è così: scorre, e chi si è visto si è visto.”

Gli chiedo perché non avesse ricordato a quella ragazza chi fosse, in guerra erano bambini e ora si ritrovavano adulti, forse davvero ella non riusciva ad associare il suo volto a quel periodo. “No, guardi…non quando vedi le bombe scendere su luoghi che conosci, non quando hai paura insieme.” Poi riprende fiato: “Certo, non avevo studiato; io sono originario di Zuccarella e sono figlio di mezzadri. Da bambino stavo con le pecore e i campi erano pieni di grano e di ulivi; ci giravo scalzo per quei campi, li tenevamo puliti e Velva aveva un altro aspetto. Anche durante la guerra, coi fascisti che avevano qui gli accampamenti, c’era da mangiare.”
“Com’erano i fascisti qui a Velva? “Tremendi ma umani”. “Come, scusi?” Sono stupita da quest’involontario ossimoro e mi chiedo che cosa Mario intenda dire.
“Le camicie nere erano delle vere e proprie bande e ci facevano paura. Io sono del Trentasette e mi sono vissuto la guerra da bambino. La guerra, quella vera, non era l’unica; i Sestresi erano sfollati per i bombardamenti ma sulle alture c’era la guerra civile, quella dei partigiani.
Così le camicie nere prendevano i contadini, gli facevano scavare la fossa e dicevano che ce li avrebbero buttati dentro. Che poi parliamo di contadini vecchi e di ragazzini: gli uomini erano arruolati. Alla fine, nonostante il terrore che provavamo ogni volta, soltanto poche persone sono state realmente gettate nella fossa, in genere lasciavano andare tutti.”
“Sì, però…”
“Anche i partigiani erano tremendi. Ci spaventavano ancora di più. I fascisti li vedevi, sapevi dov’erano. Dicevano che quella fossa era già lì nel caso avessimo deciso di aiutare i partigiani: il duce voleva dare la pensione ai contadini e i padroni non volevano, i partigiani preferivano i padroni.”
” Ma no, molti partigiani erano socialisti!” esclamo.
“Comunque sia, quelli di allora erano meglio di quelli di adesso.” conclude Mario.
Guardo lui ed Elia, sua moglie, e so che questo articolo mi prenderà del tempo, che non mi sarà chiaro né cosa scrivere né come scriverlo. Perché Mario ed Elia, quelli che stanno parlando con me adesso, sono gli stessi che conobbi bambina: immutati. Vederli nel ruolo di bisnonni attivi e giovanili mi fa un certo effetto. Elia poi mi riporta alla me bambina che andava a comprare in quel negozio che c’era a Velva e che non c’è più, non perché vi fosse la volontà di chiudere ma perché, tra gli anni Novanta e il primo decennio del nuovo millennio, Velva è morta di abbandono.
Elia è più giovane di Mario: è nata l’anno della Costituzione: “Sono vecchia ma non così vecchia da potermi essere goduta il primo voto delle donne, mannaggia!” I capelli ancora neri e lunghi, il volto dalle rughe appena accennate.

Ed è sua moglie, perché poi Mario è riuscito a lavorare negli alberghi e ha incontrato la sua dolce metà: “L’ho conosciuta al Miramare che ero già un uomo: avevo lavorato in diversi alberghi e persino in distilleria perché, qui in zona, c’era la White Rock, la fabbrica di birra.”
Mario è un uomo affascinante e diretto, sicuramente concreto, ed Elia si innamora; la coppia sceglie di vivere a Velva ed Elia si apre quello che diventerà lo storico negozio di quest’angolo tra gli Appennini. I primi anni il negozio vende bene, è un emporio che risponde a tutte le esigenze; appena i figli crescono, decidono di aiutare la madre: “Io non amavo il negozio”, ammette Mario, “mi pareva un lavoro da donne.” Invece Ugo, il figlio, ama lavorare in questo negozietto: “Ugo partiva con la sua Vespa e andava a far consegne in ogni dove mentre mia Gabriella mi aiutava al banco”. Poi, triste, Elia aggiunge: “C’erano tre negozi qui, e vendevamo tutti.” Poi il dramma inarrestabile: “Nel ’99 Velva si è spopolata; non di colpo, certo, ma nel ’99 abbiamo capito che non potevamo più competere con i supermercati. Chiudere il negozio è stato come dare l’ultima pugnalata a Velva.”
Elia aggiunge che durante il lockdown si è resa conto di come sia cambiata la mentalità della gente: “I corrieri portavano i pacchi anche quassù ma senza avere alcuna relazione con i clienti, altro che Ugo!”
“Certo,” ammette Valeria, la nipote, “però, durante il lockdown, qui siamo riusciti a vivere e molte famiglie hanno riscoperto il piacere di relazionarsi in una comunità piccola ma lontana dalle ansie che pervadono il mondo.”
“Dunque” sorrido “se mai ci sarà un nuovo lockdown, verrò qui a esplorare i sentieri di Velva.”
Ed è agosto quando pronuncio questa frase: ero sicura che non ci sarebbero stati altri lockdown.
Curioso, questo articolo avrebbe dovuto essere pubblicato su PoliticaCultura nel mese di settembre ma, banalmente, non trovavo più le foto di quella mattina così particolare.
Oggi, mentre setacciavo la cartella d’immagini, all’alba di una nuova e inevitabile chiusura, è spuntato il volto di Mario al quale mando i miei più vivi saluti; un caso, un monito, non lo so ma, da un po’ di giorni, Velva sembra chiamarmi col suo silenzio, la sua bellezza, la sua speranza.
Rosa J.Pintus